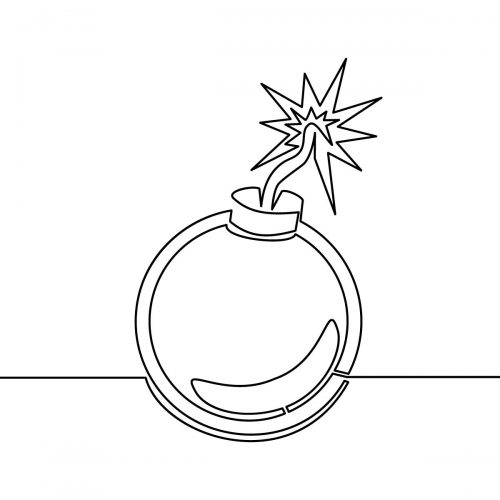
a cura di Pierluigi Musarò, professore associato presso l’Università di Bologna
Da un anno conviviamo con il Covid-19, anche noto come nemico invisibile. A render cele(b)re questa associazione mentale hanno contribuito dapprima le dichiarazioni di diversi capi di stato e di governo: da Macron che il 16 marzo 2020 dichiarò “guerra contro un nemico invisibile”, all’ex presidente del Consiglio dei ministri italiano Conte che twittava il giorno dopo “Mai come adesso l’Italia ha bisogno di essere unita. Sventoliamo orgogliosi il nostro Tricolore. Intoniamo fieri il nostro Inno nazionale. Uniti, responsabili, coraggiosi. Tutti insieme per sconfiggere il nemico invisibile”. Sino a Trump che – autoproclamatosi presidente di guerra – annunciava via Twitter un ordine esecutivo per bloccare qualsiasi tipo di immigrazione negli Stati Uniti come prima misura utile a combattere il nemico invisibile.
Teorie del complotto e infodemia
In quest’anno si sono susseguite diverse teorie del complotto, alimentate da autorità statali, partiti, gruppi nazionalisti e xenofobi, ma anche da tanti media che hanno finito per affiancare al Covid-19 il virus della disinformazione. Per quanto l’Organizzazione mondiale della sanità ha più volte denunciato il rischio di infodemia (sovrabbondanza di informazioni, non sempre accurate), da Pechino a Washington, da Mosca a Teheran, i leader politici e i mezzi d’informazione di stato hanno spesso fatto da megafono a teorie del complotto politicamente convenienti.
“Le parole sono importanti”, urlava Nanni Moretti in una celebre scena di Palombella Rossa. La scelta di un elemento linguistico non è mai neutra, ma veicola differenze nella rappresentazione del mondo. Sceglierne alcune e non altre per indicare e descrivere i fenomeni può aiutarci a comprenderli e gestirli meglio. Usando parole imprecise o distorte, fuorviamo non solo la comprensione degli eventi, ma anche le emozioni, le decisioni e le azioni che ne conseguono. Lo sapeva bene Donald Trump quando definiva “virus cinese” il coronavirus, incorniciandolo (attraverso una chiara operazione di framing) in una definizione che ne attribuisce e denuncia la provenienza e dunque la responsabilità.
La metafora bellica
Il nemico invisibile – che Donatella Di Cesare ha efficacemente definito “virus sovrano” – è un organismo minuscolo che attraversa le frontiere e costringe individui e stati-nazione a tracciare nuovi confini dentro cui trincerarsi (nazionali, regionali, casalinghi, epidermici), per ritrovarsi comunque sempre più soli, indifesi e in guerra contro tutti. La metafora bellica è stata un’altra costante di questa narrazione lunga un anno. La retorica sui medici e gli infermieri eroi, sulle corsie d’ospedale come trincee, sui vaccini come armi, ha contribuito a farci sentire minacciati da un nemico invisibile che vediamo ovunque, trasformandoci in soldati semplici, armati di gel disinfettanti e di buon senso, pronti a colpire ogni potenziale aggressore. Perpetuando così un linguaggio bellico e una retorica militaresca che riducono la sicurezza a controllo e incorniciano la realtà perpetuando la dicotomia amico/nemico. Cosa che, da un punto di vista psicologico e cognitivo, non ci ha aiutato ad affrontare l’emergenza. E ha anzi rinforzato l’idea muscolare di sicurezza come controllo e repressione, odio e discriminazione. Facendoci dimenticare che la sicurezza è anche messa-in-sicurezza, protezione, condivisione, cura. E facendoci perdere l’occasione di ascoltare i segnali (di allarme, senza dubbio) che da più parti giungono, di osservare un fenomeno nuovo e sforzarsi di trovare parole diverse per descriverlo. Un’occasione per riflettere sulla fragilità di questo sistema capitalistico globale e sulla necessità di agire verso un cambiamento sistemico del nostro stile di vita, a partire dalle relazioni tra esseri umani e tra noi e il pianeta.
Il pericolo invisibile
Dai discorsi dei politici al lessico dei giornali a quello dei social network, l’immagine del pericolo invisibile che ci minaccia è sempre presente nel racconto della pandemia. Con la conseguenza che un fenomeno già di per sé inquietante cresce di intensità ad ogni notizia riportata, in ogni scelta linguistica effettuata. Assumendo le sembianze della paura più temibile che – come scrive Bauman – è “la paura diffusa, sparsa, indistinta, libera, disancorata, fluttuante, priva di un indirizzo o di una causa chiari; la paura che ci perseguita senza una ragione, la minaccia che dovremmo temere e che si intravede ovunque, ma non si mostra mai chiaramente”.
Bauman tratteggiava questa paura generalizzata come Liquida. Oggi dovremmo forse definirla Paura Eterea, dato che lo stesso respirare è ormai fonte di sospetto. Paura che amplifica uno scenario di insicurezza totale, dove l’emergenza sanitaria provoca l’emergenza psicologica, a cui segue poi quella economica, sociale, politica. Paura che ci deve far riflettere sulla relazione sottile e pericolosa che lega pandemia, infodemia e fobocrazia (il potere esercitato attraverso l’allarme prolungato).
Incertezza, ansia e paura sono infatti le emozioni tipiche di questo periodo di emergenza, troppo spesso alimentate e manipolate dalla propaganda politica e dai mezzi di (dis)informazione contemporanea che, diffondendosi attraverso l’intera gamma di dispositivi comunicativi, finiscono per creare una specifica visione del mondo.
Sfruttata, modellata, ufficializzata, la paura passa da emozione individuale a forza costitutiva della realtà sociale, utile per assicurarsi la sottomissione e l’obbedienza dei membri di una “comunità immaginata” (come Benedict Anderson definiva la nazione) che promette un senso di fraternità e sicurezza ai suoi membri, evidenziando di contro la barbarie e la minaccia rappresentate dall’altro esterno, spesso ridotto a capro espiatorio.
Alla ricerca del capro espiatorio
D’altra parte, scriveva René Girard, quando l’ansia sociale diventa difficile da gestire, quando la società è vicina all’implosione, il capro espiatorio previene il collasso. Nelle società in crisi, per tenere a bada l’ansia, il branco cerca una vittima, ne dimostra la colpevolezza e poi la bracca, la circonda, la crocifigge, la isola, la arresta o la deporta. Una vittima di per sé innocente, ma che viene giudicata colpevole solo perché c’è un indizio che testimonia la sua relazione con le cause (indeterminate e indecifrate) della crisi. E chi se non gli stranieri come capro espiatorio della crisi?
In questa logica di comunione, la paura degli stranieri ha un duplice scopo: da una parte proietta all’esterno gli aspetti considerati indesiderabili, dall’altra radica all’interno quelli considerati accettabili per l’identità nazionale.
Lo sanno bene alcuni politici e hater di professione che i discorsi nazionalisti dell’appartenenza si fondano su una definizione dell’altro come un’entità esterna e terrifica. Che la minaccia dei barbari costituisce un buon diversivo all’erosione della sovranità territoriale e un ottimo volano per condurre i cittadini a riporre le speranze in un salvatore, un uomo della provvidenza che attraverso un nazionalismo bellicoso e discriminatorio prometta di chiudere le porte al pianeta globalizzato e ristabilire l’ordine in casa.
E lo dimostrano i dati sull’odio rivolto agli stranieri dipinti come untori, ai migranti accusati di portare il virus in Italia, come già nel diciassettesimo secolo a Napoli si identificavano i forestieri come la causa della peste. In un tiro continuo al bersaglio, dall’arrivo della pandemia, dapprima sono stati accusati i cinesi che a Prato si accingevano a festeggiare il loro Capodanno, poi i migranti che via mare avrebbero portato il virus. Al punto da confinarli (sebbene negativi al tampone) in navi quarantena e segnalarli nelle statistiche ufficiali di certe regioni con un asterisco, a indicare la loro terrifica diversità.
I migranti invisibili
Se i diversi studi condotti sul tema della copertura mediatica sulla migrazione negli ultimi anni evidenziano come la rappresentazione offerta è principalmente quella di vittime da compatire e personaggi senza una propria voce, oggetti disumanizzati all’interno di frames che aumentano la percezione di crisi sociale, anche quando questa non è in atto; nei mesi di confinamento forzato nella nostra sovranità casalinga abbiamo assistito ad un duplice fenomeno. Dapprima è scomparsa dal dibattito pubblico la pressione sui confini di quanti tentano di entrare irregolarmente in Europa. Per quanto le persone costrette a rischiare la morte nel Mediterraneo per cercare asilo sull’altra sponda non si siano mai fermate – né lungo il confine tra Turchia e Grecia o tra Bosnia e Croazia -, la cosiddetta “emergenza migranti” – sulle prime pagine dei giornali per (troppi) anni e fino a pochi giorni prima – nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 è stata praticamente oscurata dallo sbarco in Europa del nemico invisibile. Lo confermano i dati dell’ultimo rapporto Carta di Roma. L’ipervisibilità dell’emergenza covid-19 ha reso invisibile quella dei migranti che (da anni e ancora oggi) premono ai confini dell’Europa. L’emergenza virus ha chiuso la frontiera su di noi. I confini, e la relativa paura di chi li attraversa, sono diventati l’aria che respiriamo, la mascherina, la nostra pelle.
Mentre sulle rive del fiume Evros si consumavano feroci violazioni dei diritti dei migranti (respingimenti alla frontiera, violenze fisiche, detenzioni illegali), l’emergenza coronavirus ha fatto si che il Vecchio continente decidesse di blindare (ancora con più forza) i confini, dimostrando ancora una volta la propria inflessibilità e indifferenza con i potenziali rifugiati al di là della frontiera. Una risposta in linea con il collasso della solidarietà intraeuropea e le politiche securitarie che da decenni caratterizzano il fronte migratorio. Nel momento in cui l’Europa diventava l’epicentro della pandemia, Michael Ryan – direttore esecutivo dell’Oms – lanciava un appello in favore delle popolazioni invisibili: “Non possiamo dimenticare i migranti, non possiamo dimenticare i lavoratori senza documenti, non possiamo dimenticare i detenuti”. Invitandoci a riflettere sul fatto che per quanto da molti il virus sia stato descritto come democratico, in verità colpisce in modo particolare le fasce più deboli e invisibili della popolazione. Il tasso di mortalità degli afroamericani negli Stati Uniti fa ben comprendere come essere invisibili si traduca nell’impossibilità di accedere a servizi fondamentali, e in particolare alla sanità.
Il Decreto Rilancio n. 34 del 2020
Così, dopo i primi mesi di invisibilità, i migranti hanno riacquistato (iper)visibilità con la faticosa approvazione del Decreto Legge del 19 maggio 2020 n. 34, la cosiddetta sanatoria per far emergere dal nero i migranti considerati “lavoratori essenziali”, migliaia di braccianti agricoli, spesso invisibili e sfruttati, che lavorano nelle campagne italiane per garantire l’approvvigionamento di frutta e verdura. Uno tra i provvedimenti del Decreto Rilancio adottati per reagire agli effetti devastanti della pandemia che ha permesso alla ex ministra per le Politiche agricole Teresa Bellanova (che pure ha lavorato come bracciante, lottando poi come sindacalista contro la piaga del caporalato), di annunciare commossa “Da oggi gli invisibili saranno meno invisibili”.
Per quanto nasca con i migliori intenti (in primis, per tutelare la salute personale e pubblica), si tratta di una ‘regolarizzazione’ che è frutto di un difficile compromesso politico, evidente nelle diffuse aporie del testo normativo e nei numerosi ostacoli presenti sia nei presupposti, sia nelle procedure.
L’iter del decreto non fa che esplicitare (se mai ce ne fosse bisogno) le dinamiche sociali dell’Italia come paese di accoglienza, svelando le caratteristiche di una comunità ricevente che altrimenti rimarrebbero latenti. Una comunità il cui istinto identitario e sovrano viene fomentato da una percezione distorta dell’immigrazione, più propenso a vedere gli altri come non persone, braccia da sfruttare, corpi da respingere, dati da esporre, rifiuti da smaltire. Una comunità che, ancor più a causa della pandemia, rischia di distanziare il prossimo nell’ossessione della sicurezza, di abolire l’altro per il rischio di essere contagiati, di perdere il dono dell’apertura e dell’ospitalità inseguendo l’iper-protezione di una psicopolitica immunitaria.
Un destino senza frontiere
Eppure, se il virus globale insegna qualcosa è che oggi la comunità chiusa e sovrana è ormai un miraggio e che i muri eretti dagli Stati nazionali contro il nemico invisibile sono ridicoli e inefficaci. Sia questo nemico il Covid-19, il terrorismo, il cambiamento climatico o il migrante. Bisognerebbe piuttosto riflettere sull’impatto che la copertura mediatica attuale sta avendo sulla società. Riformulare la narrazione sulla migrazione includendo le voci dei protagonisti, che sono persone (e non dati), con le loro storie per cui hanno lasciato i loro paesi rischiando la vita nel loro viaggio verso l’Europa, con le loro professionalità e aspirazioni. Migliorare dunque le pratiche mediatiche relative alla migrazione e, più in generale, incentivare narrative diverse per definire quel che sta accadendo, sperimentando schemi e discorsi capaci di aprire nuove possibilità di solidarietà e giustizia sociale, senza più ignorare un comune destino di vulnerabilità. Un destino, volenti o nolenti, senza frontiere.
